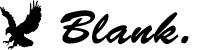La cinematografia americana ci ha così tante volte propinato analisi – spietate e crude , a volte; moralistiche, altre – del mondo crudele, cinico e baro di Wall Street, che la prima domanda che viene alla mente al termine della visione de The Wolf of Wall Street è: ma perché Martin Scorsese ci ha fatto sopra un altro film e, per di più, di tre ore?
Forse per la semplice ragione che non è un film su e contro gli ‘eccessi’ di Wall Street (le nefandezze strutturali di Wall Street, messe in luce dall’amara realtà della crisi finanziaria del 2008-2009, vengono sempre definite ‘eccessi’, quando invece sono la regola); perché non è una critica al capitalismo che certe ‘distorsioni’ crea in modo circolarmente ciclico; perché non vuole criticare niente e nessuno, tutt’al più, prende atto.
La storia di Jordan Belfort (quello vero, che poi sulle sue vicende ci ha scritto un libro) è la storia, squallida e usuale, di uno dei tantissimi squali della finanza newyorkese: l’importante è fare soldi, perché i soldi comprano tutto (donne, droga, case , auto, lusso, yacht). Come si fanno, non ha alcuna importanza, perché alla fine della giostra poi, se va male, puoi sempre collaborare, fare la spia e cavartela con 20 mesi di carcere.
Il Jordan Belfort , il lupo in questione, di Scorsese (Leonardo Di Caprio) è prima di tutto un drogato: crack, cocaina, morfina, alcol a go-go e qualsiasi altra cosa che non faccia pensare e faccia rilassare ( e, quindi, sesso a rotta di collo con tutto ciò che scopabile: prostitute da 50 dollari, escort di lusso, zie della terza età, mogli e concubine. Anche un continuo e sano autoerotismo onanistico).
Scorsese ci ripropone tutto questo in modo massiccio, continuo, ripetitivo: la Stratton Oakmont, la società di brokeraggio fondata da Belfort, sembra il girone infernale della lussuria elevato all’ ennesima potenza e imbottito di cocaina fino e oltre ogni limite. Forse Scorsese fa i conti con i suoi eccessi giovanili, da una parte, mentre, dall’altra, da buon cattolico romano, come si definisce, si astiene dallo scagliare sia la prima che l’ultima pietra.
Belfort/Di Caprio, tutto sommato, è un personaggio simpatico agli occhi di Scorsese: cerca di costruirsi il suo paradiso in terra. Tutto tra il porno, il delinquenziale e il grottesco.
Il regista italo/americano ci propina, su 3 ore di film, due ore abbondanti di sedute di droga, solitaria o in compagnie oceaniche, culi tette passere rasate o villose, trombate in tutte lo posizioni, pompini a manciate: con una ripetitività parossistica. E’anche un modo per creare l’ossessione che domina il personaggio, ma alla fine annoia. Scorsese vuole mettere a nudo, anche in senso fisico, il lato torbido e oscuro delll’uomo (e della donna, considerando la non certo bella figura che ci fanno le donne nel film). Ne viene fuori un pastrocchio psicanalitico, che mostra solo cosa fanno certi americani in certe situazioni, quando cercano di massimizzare una delle regole di vita statunitensi: fai i soldi e cerca di essere il numero uno.
All’interno di questo quadro sostanzialmente negativo emerge, tuttavia, la capacità corale degli attori di dare vita a un affresco del marcio che sta nelle viscere di New York ( e in generale della società americana): una o forse due spanne sopra tutti, un grande Leonardo Di Caprio, che non si riesce a capire perché non vinca mai l’Oscar: forse perché troppo bello. Peccato, per l’Oscar, intendo.
Tutti i film vanno visti, per poterli giudicare. Si può vedere anche questo.