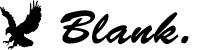Che la prima svalutazione, di circa il 2 per cento, non fosse quella definitiva era abbastanza chiaro: troppo poco per l’obiettivo ufficiale che si prefissava. I due aggiustamenti successivi sono più appropriati e hanno anche la benedizione del FMI.
Che l’obiettivo sia la difesa delle esportazioni è una mezza verità: la posta in palio è più alta ed ha valore storico e non congiunturale.
Dunque, alla fine di un ventennio di crescita vertiginosa, che nemmeno Deng Xiaoping avrebbe mai immaginato ( e sperato), la Cina si trova a fare i conti con quello che gli oligarchi di Pechino giudicano un preoccupante rallentamento dell’economia nazionale.
I gerarchi del Partito Comunista cinese sono da qualche giorno, come ogni anno fin dai tempi di Mao, in vacanza a Bedaihe (una specie di Rimini a sud di Pechino) e come ogni anno si vedono in modo ‘informale’ , cioè al di fuori delle riunioni del Politbureau o del Comitato centrale, o dei vari Comitati Permanenti delle assemblee elettive (per modo di dire). Gli incontri sono informali, ma le decisioni sono ufficiali. Non sorprende, quindi, che la decisione di svalutare sia venuta in questi giorni: il Partito ha deciso e la Banca Centrale ha implementato, alla faccia dell’indipendenza della politica monetaria, sulla quale noi europei e gli americani ci scanniamo da decenni. Su quali dati ‘oggettivi’ è stata presa la decisione?
La situazione economica, al netto delle turbolenze borsistiche (esagerate a dismisura , probabilmente con l’obiettivo di una parte del Partito di mettere fine ai soldi facili delle varie cordate che controllano il potere politico-economico cinese, ma non certo per garantire le famiglie e i risparmiatori, peraltro – secondo una recente analisi dell’Economist- partecipanti solo con una quota dell’1,5% al mercato finanziario interno), non è critica, neanche a misurarla con gli occhi dilatati della dirigenza cinese: il PIL crescerà nel 2015 del 7% , in linea con gli obiettivi: le riserve valutarie sono stabili al di sopra di 3.800 miliardi di dollari; la produzione industriale cresce. Nel rapporto di marzo, l’OCSE salutava con favore il rallentamento della crescita cinese, condizione per poter reimpostare ( se ce ne fosse l’intenzione) il piano di sviluppo su basi più equilibrate.
Ma ci sono anche altri dati, più o meno ufficiali, con cui fare i conti.
La situazione strutturale di sovrapproduzione delle aziende statali, che accedono senza problemi al credito a buon mercato, è, appunto, strutturale: le aziende manifatturiere statali raggiungono sempre, anzi superano brillantemente, i target quantitativi del piano quinquennale, ma i loro magazzini sono pieni (stracarichi) di merce invenduta.
Il settore agricolo vede sempre di più allargarsi la forbice che lo divide da quello industriale e dei servizi: la produttività e i rendimenti sono bassi, troppo bassi rispetto al fabbisogno nazionale.
Nell’ultimi cinque anni il tasso di cambio reale si è apprezzato di quasi il 30%, mentre il mondo andava in direzione opposta: solo nell’ultimo anno (agosto 2014- agosto 2015) l’euro si è svalutato rispetto al dollaro di quasi il 18%, il real brasiliano del 38%, lo yen giapponese del 15, il rublo del 50 (dopo aver toccati picchi del 100%), il won coreano del 10%, il dollaro canadese del 16 e stessa sorte per quello australiano.
La competizione sui costi (soprattutto del lavoro) non basta più o, quantomeno, non è più sufficiente a garantire i tassi di crescita dei decenni passati.
Una mossa, quindi, quasi obbligata: strano è che gli analisti e gli osservatori internazionali non ne avessero capito l’ineludibilità.
Ma nella mossa del gruppo dirigente cinese c’è qualcosa di più importante sul lungo termine, qualcosa che può minare per sempre l’impianto di sviluppo inaugurato in Cina negli anni ’80. Ed è l’accordo di libero scambio tra USA e UE, su cui tanto insiste (giustamente) Obama. Se l’accordo dovesse andare in porto, la Cina verrebbe derubricata dalla prima fila nello scenario mondiale: UE e USA diverrebbero il più grande mercato mondiale, inarrivabile, con regole di favore tra le due parti cui altri non potranno accedere.
Creare un disequilibrio permanente sul mercato dei cambi è un modo per tenere l’economia mondiale in situazione precaria: e nelle situazioni precarie è difficile che si portino a termine operazioni ambiziose come quelle cui punta Obama.
La Banca centrale cinese ha fatto sapere oggi che le svalutazioni attuate sono un primo passo per portare lo yuan alla libera contrattazione sul mercati valutari. Ciò significa nel lungo termine che lo yuan potrà essere considerato, a tutti gli effetti e con tutti i diritti, una valuta di riferimento ( e di riserva) come il dollaro o l’euro. Quanto durerà questa strada di avvicinamento alla libera contrattazione non è dato sapere. O cioè sì: tanto quanto basta alla Cina per tornare a mettere i piedi, il naso e le mani negli affari degli altri. Gli stessi che considerano la Cina un’opportunità e non, come dovrebbe, una minaccia.