L’Italia e l’Europa si trovano, in queste convulse e singhiozzanti fasi finali della crisi economica che ha messo in ginocchio il mondo intero dalla fine del 2008, ad attraversare un immenso guado, dalle acque basse ma limacciose e apparentemente senza fine: l’attraversamento è ancora lento, faticoso, incerto. La mitica luce in fondo al tunnel non è uguale per tutti e non sempre brilla della stessa intensità: ma , a meno di un altro shock grave e irreversibile (un nuovo fronte di guerra, il crack di qualche banca di peso mondiale, una catastrofe naturale di dimensioni apocalittiche), la fine della crisi o almeno il superamento di quasi tutti i peggiori mali sembrano vicini, prossimi. A metà 2015 potremo, facendo tutti gli scongiuri del caso, brindare , seppure con moderazione. E’ di oggi la notizia, dopo i dati confortanti sull’andamento del PIL e sulla produzione e l’occupazione, che l’indice della fiducia dei consumatori è arrivato, secondo l’ISTAT, a 110,9, il punto più alto dal 2002, cioè 13 anni fa. Non è male.
Come tutte le crisi quella che ancora stiamo vivendo ha imposto a tutti l’imperativo di compiere delle scelte: il guado si attraversa solo e unicamente se si ha o se si è avuto il coraggio di cambiare, di riconoscere gli errori, di mettere in movimento nuovi processi, lasciandosi magari alle spalle convinzioni e schemi consolidati, tutto ciò che per molto tempo è stato un punto di riferimento e una sicurezza. Tutti abbiamo una coperta di Linus, cui non possiamo rinunciare. Anche i Governi, la politica, le grandi nazioni. Coperte morbide e collettive, per questo ancor più difficile è lasciarle per imboccare nuove strade.
L’Unione Europea è soffocata dalle tante coperte in cui si avvoltola, in cerca di sicurezza: alcune nazionali, altre unitarie; alcune ancora valide, altre superate già da tempo dal cammino della Storia; alcune logore ma logiche, altre logore ma assolutamente irrazionali.
Siamo in questa fase di stagnazione e deflazione perché la Destra tedesca (ma non solo) è ancora ossessionata dalla Repubblica di Weimar e dall’iperinflazione, dimenticando o fingendo di dimenticare che in mezzo ci sono la Seconda Guerra, Bretton Woods, la Corea, la CEE, il Vietnam, l’abolizione dell’apartheid in America e poi in Sud Africa, la penicillina, la conquista dello spazio, i computer e internet, la caduta del Muro di Berlino. E mi fermo qui. Ma l’inflazione sopra il due per cento a Monaco, Berlino e a Francoforte mette paura, anche se i nazismi o i nuovi fascismi che girano per l’Europa, oggi, non sono figli dell’inflazione, bensì della crisi e dell’austerità. Una coperta logora e irrazionale, con cui però dobbiamo fare i conti tutti e non solo Tsipras, perché è in mano alla Germania.
Le socialdemocrazie europee e le sinistre radicali , con accenti diversi ma fondamentalmente sulla stessa lunghezza d’onda, non vogliono lasciare la coperta del welfare: giustamente, direi, ma i costi e i prezzi – se non si aggiustano un po’ di storture strutturali- non si possono più sostenere. Una coperta logora, ma ancora valida, a certe condizioni.
In Italia siamo aggrappati a decine di coperte di Linus: da Maastricht in poi i processi di liberalizzazione hanno messo a nudo i limiti strutturali dello sviluppo economico italiano, del capitalismo, furbetto e dal fiato corto, delle Partecipazioni Statali e delle piccole imprese. A noi, anello debole dell’alleanza atlantica, con in casa il più grande partito comunista dell’Occidente e ai confini con i nemici della guerra fredda, ci è stato concesso di tutto: stampare senza limiti moneta, aumentare a dismisura il debito pubblico, svalutare a ciclo continuo la lira, per recuperare sul prezzo le inefficienze di un sistema economico asfittico, malato di nanismo, distorto dalla corruzione. Ma questa grande coperta della Guerra Fredda e del mondo diviso in blocchi non c’è più: l’UE che abbiamo contribuito a costruire è un’Europa a libera circolazione di capitali, persone e merci. Il libero mercato, insomma, nei limiti del possibile.
Abbiamo urgentissimo bisogno di cambiare, prima che nei fatti,nelle nostre menti. Abbiamo bisogno di mettere sotto la lente d’ingrandimento di una critica serena ma serrata centinaia di convinzioni; dobbiamo ridefinire le categorie e risintonizzare la strumentazione di analisi al mondo che cambia o che è cambiato alla velocità della luce negli ultimi venticinque anni (elenco solo alcuni cambiamenti: crollo dell’Unione Sovietica e del blocco comunista; diffusione di massa di internet e della telefonia cellulare; Cina primo paese al mondo per PIL; globalizzazione economico-finanziaria; introduzione euro; crisi 2008-09. Per avere cambiamenti di pari portata, prima, ci erano voluti 100-150 anni). La fase che attraversiamo, cominciata nei primi anni ’90, e che probabilmente arriverà alla conclusione, almeno del primo ciclo, quando saremo usciti da questa crisi, quindi più o meno un paio di anni ancora, è una fase epocale. Epocale nel senso che il mondo sarà alla fine completamente diverso da quello che, fatte le dovute differenze dovute al naturale sviluppo, abbiamo conosciuto negli ultimi due secoli.
Cambiare si deve, quindi, per evitare che i processi ci scappino di mano e si sviluppino senza di noi o, peggio, contro di noi. Ma cambiare è difficile, perché impone di mettere in discussione quello che eravamo, esige che ri-valutiamo le idee con cui siamo cresciuti, richiede di schierarsi e di farsi carico anche degli inevitabili errori, perché – come è noto- solo chi non fa non falla.
L’Italia convulsa e contraddittoria degli tre anni, dalla caduta del governo Berlusconi ad oggi, è un Paese che si dibatte in molte, a volte angosciose, antinomie: esigenza di cambiamento di alcune leggi fondamentali (inclusa la più fondamentale di tutte, la Costituzione), per rimettere in moto una società bloccata a quasi tutti i livelli. Economico, dopo lo schianto del 2009, con seri segnali di deinustrializzazione permanente e la disoccupazione a livelli mai raggiunti prima; istituzionale, con la necessità di ridisegnare l’intero impianto sia centrale che territoriale, per uscire dal pantano di un sistema che non garantisce la governabilità dei processi; politico, per eliminare la montagna di fango che una classe di amministratori, non di rado incompetenti e spesso anche corrotti, ha gettato su tutto il sistema.
Tutti sono d’accordo, o quasi, perché c’è chi si limita, ancora oggi, solo alla denuncia senza offrire alternative, credibili o viabili.
Tuttavia, al momento opportuno distinguo, mal di pancia, posizioni acquisite da difendere, ideologia, interessi di partito o, peggio, di corrente, antipatie personali e tutto quello che concorre alla creazione di ostacoli e veti, emerge nella sua plastica evidenza.
E’ il caso emblematico dei due ultimi provvedimenti del governo Renzi: il cosiddetto Jobs Act, cioè una legge sul lavoro, e la nuova normativa sulla responsabilità civile dei magistrati. Sul secondo provvedimento l’atteggiamento dei magistrati è stato ondivago, con posizioni differenti tra le varie correnti politiche, ma con un sostanziale rifiuto, perché ritenuto lesivo dell’autonomia e della libertà delle toghe, rosse o nere che siano.E, apparentemente, senza confronti muro contro muro: per vedere quale saranno gli effetti occorre almeno un anno. Niente sciopero, per evitare le (giustamente) inevitabili critiche di corporativismo, ma attacco frontale alla legge, con un fuoco di sbarramento giornaliero e ad ampio spettro.
Più drammatico, almeno nelle forme, il confronto sul Jobs Act. Governo e maggioranza del PD si trovano contro un arco di forze, minoritarie ma molto articolate, che vanno dalla CGIL alle minoranze del PD, che – va detto- non vanno oltre il 20% del Partito, dalle opposizioni della destra (FI e la Lega, dando per scontata l’opposizione ‘ a prescindere’ del M5S) a SEL. E’ stato detto di tutto: neoliberismo, tachtcherismo, deriva autoritaria e via di questo passo. Del simulacro oggi esistente dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori è stato fatto un totem inviolabile. Gran parte (graziaddio non tutti) degli ex comunisti del PD, che non sembra si renda conto dei contesti in cui certi cambiamenti diventano una necessità, mette sotto accusa giorno dopo giorno, ormai da mesi, il Segretario del Partito nonché Presidente del Consiglio. In questa opera demolitoria e plasticamente conservatrice, si mette in mostra quotidianamente l’on. Fassina, che trova sempre un nuovo pretesto per un nuovo fronte di polemica. Dimenticando sistematicamente due cose: la prima, che il Congresso è finito da un pezzo e le sue tesi ne sono uscite sconfitte, senza se e senza ma; la seconda, che in un partito , democratico e di massa, ci si sta a certe condizioni – dopo discussioni, votazioni, divisioni – in modo unitario: poi alla fine tutti si devono far portatori della linea vincente.
Ma cambiare è un atto difficile: molto più facile adagiarsi su vecchi slogan, vecchie consuetudini, vecchi schemi. Dal vecchio non vengono mai sorprese, ma, ahinoi, neanche cambiamenti.
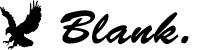

Non riesco a venire a vedere che racconta “Cantami o Diva”. Oggi si. A margine della precedente nota sulle difficolta’ del cambiamento, mi viene da dire che oggi ho visot per la prima volta “The Mission” film del 1986. La storia che racconta “monta” momenti storici diversi ma che vengono datati 1751, cioe’ 21 anni prima la nascita degli Stai Uniti e 38 anni prima della Rivoluzione Francese. E in “The Mission” , nel 1751, si parla di schiavitu’, con tutto quello che ne consegue, come una cosa normale. Beh, negli ultimi 100 anni siamo andati avanti ben piu’ velocemente, come ben sottolinea Roberto e certo non in modo lineare, ma mantenendo una direzione. Non considerare oggi la velocita’ del cambiamento, come variabile rilevante dello stesso, e’ oggettivamente sbagliato.
Bellissimo film , peraltro. Dal 1751 siamo dovuti arrivare fino al 1863 per l’abolizione della schiavitù (formalmente) e per mettere fine (sempre formalmente)al segregazionismo siamo dovuti arrivare al 1964-5 (Civil Rights e Voty Rights). La rivolta di Watts fa , nel 1965, 34 morti più di mille feriti e 4000 arrestati. Le Pantere Nere cominciano allora. E ancora oggi gli Stati Uniti non ne sono fuori, anche se la discriminazione adesso è più di classe che di razza (ma attenzione: nel censimento americano si usano ancora i concetti di classificazione in base alla ‘razza’! – principio già in sé razzista).
Tuttavia non dobbiamo confondere il progresso, inteso come miglioramento totale del benessere, inclusa istruzione , verticalità di sviluppo, osmosi di classe, allargamento degli spazi di partecipazione democratica, allargamento dei diritti delle fasce deboli (portatori di disabilità, donne sole, soggetti non normo classificabili), rispetto dell’ecosistema (sostenibilità della crescita, inquinamento, diritto alla salute, profitto come misuratore di efficienza e non come fine ultimo dei processi produttivi) con la crescita della produzione, del reddito e dei consumi: quello è sviluppo economico.
L’Occidente (Europa + USA, Canada, forse Australia e Nuova Zelanda) hanno forti identità, archetipi e radici comuni: figli, in ogni caso, della cultura greco-romana, del cristianesimo, del Rinascimento – la più grande conquista del rinascimento europeo è la scoperta dell’America- o del calvinismo (in povera sintesi, ma per capirci: Socrate, Platone, Aristotele, Cristo- San Paolo, Plotino, San Tommaso, Cartesio, Pascal, Newton, Hegel, Marx, ). In Cina non sanno nemmeno scrivere questi nomi: per capirci, per scrivere Stalin scrivono tre ideogrammi il cui primo significa 4, il secondo ‘grande’, il terzo ‘zero’. Vado a mente, ma qualcosa di simile. In Giappone hanno inventato un apposito alfabeto per le parole straniere. Il Giappone è fuori dal contesto mondiale fino al 1945 (l’ammiraglio Perry li aveva cannoneggiati, Mac Arthur – grande massone , come i padri fondatori- gli ha tirato la bomba atomica).La Corea fino al 1988. La Cina fino al 1989. L’India e tutta la penisola ampiamente indiana sono ancora fuori dalle idee che hanno fatto sviluppare il mondo.
Alla fine del ‘500 con delle barchette di venti metri i Portoghesi sono arrivati a Goa e a Macao e poi sono andati in Giappone: agli indiani e ai cinesi di andare a scoprire ‘l’America’ non è mai fregato nulla. Perché non hanno l’idea innata di scoperta, tutt’al più di invasione.
Mi puoi dire: ma chi ti ha detto che la nostra cultura è superiore alla loro? Il semplice fatto che le conoscenze scientifiche nate dalla nostra cultura sono le stesse che loro usano per la crescita economica, mentre il sistema sovrastrutturale è ancora feudale.
Il pericolo è che le idee di ritorno (guarda la quantità di deficienti occidentali che si convertono all’Islam e vogliono distruggere l’Occidente) possono , e in parte già lo sono, più forti delle nostre idee forti, quelle per capirci che ti rendono giustamente orgoglioso dei progressi che abbiamo accumulato in 300 anni, perché contemporaneamente lo strapotere del sistema di produzione asiatico sta diventando incontenibile. A oriente ignorano il concetto di separazione tra tempo di lavoro e tempo libero: a Pacific Palisades vicino casa di Romeo c’era un drug store gestito da una famiglia di coreani (padre, madre e due figli) che era aperto 365 giorni l’anno per 24 ore. Per far rilegare un fascicolo di poesie, a San Giorgio di Acilia, debbo andarci prima delle 12:30 e dopo le 16:00. Come si dice: ma va a fan culo!
Perciò: dobbiamo salvare il nostro capitalismo, e, se possibile, abbattere il loro sistema. Altrimenti Blade Runner, magari the sequel.
Spero che tu abbia solo parzialmente ragione e che il loro sistema feudale, infestato dai nostri vibrioni massonico-giudaico-plutocratici e non potendo sopportare piú a lungo la contraddizione fra struttura e sovrastuttura, arrivi ad una nuova sintesi dove i drugstore coreani si trasformino in pizzerie accettabili dalla 19,30 alle 00.30 e in cornetterie di media qualitá a partire dalle 05.00 e dove il tuo rilegatore di San Giorgio di Acilia, magari con l´aiuto di un cinese convertito di Piazza Vittorio, tenga aperto un pó piú a lungo!