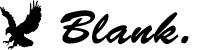Raccontare la trama di un film come Grand Budapest Hotel non ha senso, perché la storia ha poco a che vedere con quello che il film, per quel che si percepisce al primo impatto o se ne ricava dopo una lunga riflessione, ha da dire e vuole dire. Se dovessi accostare, epidermicamente, Grand Budapest Hotel a un altro film, ciò che mi viene alla mente è Gli ultimi fuochi di Elia Kazan (che non a caso, forse, in inglese si intitola The last Tycoon): anche in questo film la storia in sé non ha niente a che fare, se non marginalmente, con quello che vuole dire il regista.
Ma qui nasce subito un grande e serio interrogativo: cosa vuol dire Wes Anderson?
La critica internazionale (che nel 90% dei casi è tra affascinata ed entusiasta di Grand Budapest Hotel) ha offerto innumerevoli sentieri di lettura, quasi tutti però , alla fine, concordi su una cosa: Wes Anderson ci parla della bellezza e della cura della bellezza che bisogna mantenere in ogni contesto e in ogni epoca, in questo mondo apertamente barbaro e rozzo, che della bellezza vede solamente la parte venale. E non è poco, anche detta così, in quattro parole riassuntive.
La cura del particolare, lo standard sempre alto dei servizi, la personalizzazione parossistica del rapporto con il cliente (che con le ricche ed attempate frequentatrici arriva anche al rapporto intimamente interpersonale di questo genio della concierge che è Monsieur Gustave -un sempre eccellente Ralph Finnes) è la sovrastruttura ideologica che tiene in vita un altrimenti decadente grand hotel.
La contestualizzazione della storia, tuttavia, in questa evidente Ungheria alla fine della propria esistenza di Paese libero e sovrano, prima invasa dai nazisti e poi annichilita dai comunisti, sembra il canto di un come eravamo (di qui il richiamo agli Ultimi fuochi di Kazan) prima che il mondo conoscesse la barbarie. Se l’ispirazione sono le storie di Stefan Zweig, Anderson ci mette del suo e a piene mani: intanto perché Zweig muore suicida nel 1942, peraltro in America, e non può essere il narrante della storia , in contesti che non può nemmeno immaginare ( il socialismo realizzato post bellico in Ungheria o nell’Europa dell’Est). Grand Budapest Hotel è ideologicamente la versione cinematografica del romanzo La donna giusta di Sàndor Màrai: un mondo perfetto che il ‘900 stava faticosamente costruendo è crollato sotto i colpi del nazismo prima e del comunismo dopo.
Tesi incantevole, ma fragile. E così il film, costruito con maestria e sostenuto da un cast di attori all’altezza della situazione, dà un senso di pieno e di vuoto allo stesso tempo: affascinante nelle ipotesi, debole nella costruzione della narrazione di ciò che c’è oltre la storia.
Vincerà in qualche modo l’Oscar.
Da vedere e, forse, da non perdere.