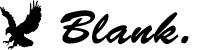Nella sua introduzione alla messa in scena da lui diretta e interpretata, Elio De Capitani scrive: “Pensavo che il tema di Morte di un commesso viaggiatore fosse la menzogna e invece è l’apparenza, quel ‘far finta’ che non è altro che la perenne costruzione di noi stessi per come vogliamo apparire”.
Certo è che l’apparenza è un dei temi cardinali del dramma di Arthur Miller, che dominò la scena di Broadway nel 1949, in pieno inizio del boom economico e della guerra fredda, con quel seguito di caccia alle streghe che fu il maccartismo, di cui – ovviamente e proprio perché non solo di apparenza Miller parlava- il drammaturgo americano fu vittima.
Come sempre Miller costruisce tragedie all’interno delle quali si intrecciano piani narrativi diversi e riflessioni su temi a ‘complicazione esponenziale’. La storia di Willy Loman, piazzista che batte la provincia e le città da New York a Boston, è la storia semplice e lineare di un piccolo-borghese americano: casa con il mutuo da pagare, benessere fatto a cambiali, una moglie che chiude gli occhi costantemente sulla durezza della realtà, due figli senza arte né parte, che non sono e non saranno mai niente nella vita, un’amante giovane con cui cerca di sfuggire alla sua squallida vita di venditore . Ossessionato dal successo del fratello morto (che ritorna periodicamente nelle sue allucinazioni, quando sconta con amarezza l’abisso tra ciò che poteva essere e quello che inesorabilmente è stato ed è), vessato e aiutato da un vicino di successo, deriso e dimenticato dai vecchi clienti, licenziato dal figlio del principale per cui ha lavorato tutta una vita. Un omino piccolo piccolo, che crede di essere l’incarnazione del successo e della American way of life, mentre non è altro che un pover’uomo che si dibatte tra rate che scadono, bollette salate e necessità – per sé e per gli altri- di mantenere il suo decoro, costi quel che costi. Perché prima o poi il successo ( e i conseguenti soldi) arriveranno. Ma ha sessantatre anni e il tramonto è vicino. Per mantenere questo decoro, per non venire meno all’apparenza, Willy si fa prestare da Ben i soldi per pagare la sua assicurazione sulla vita. Cosa che fa, poi esce di casa e si va schiantare con la sua auto malandata. L’assicurazione garantirà una vita onorevole alla vedova e ai figli. Al suo funerale non ci sarà nessuno, se non la famiglia e Ben con suo figlio Bernard ( loro sì vera incarnazione della vita di successo).
Miller demolisce dall’interno e con largo anticipo il mito della middle class americana, che diventerà, negli anni ’50 dello scorso secolo, il modello culturale e sociale per tutti i Paesi occidentali. Lavorare per avere, sempre qualcosa di nuovo: un’automobile che, quando all’ultima rata sarà tua, sarà pronta per la rottamazione; una casa di cui pagherai il mutuo fin quando sarai vecchio e sarà vuota e inutile, perché i figli se ne saranno andati: un frigorifero ancora da pagare e sempre mezzo vuoto. Per Miller (non solo per lui, ovviamente, ma lui riesce a creare un dramma dal forte pathos parlando politicamente di questi temi) il capitalismo produce bisogni e ti vende merci non per il lor valore d’uso, ma per il loro valore di scambio: hai tanti oggetti e quindi sei qualcuno (dove avere conta molto di più di essere; anzi, sei in quanto hai, senza mezzi termini). Miller anticipa, con una capacità di visione che solo i grandi hanno, la critica alla società dei consumi e dei falsi bisogni, quella per intenderci in cui siamo beatamente immersi, senza battere ciglio, da almeno cinquant’anni e che con la globalizzazione e l’esplosione della rivoluzione digitale ha raggiunto vette inimmaginabili.
È chiaro che la destra americana individuasse in questo testo ‘elementi anti americani’. Anche se lo era solo per la coincidenza storica tra quell’ America e il nuovo capitalismo post bellico.
Testo lungo, complesso, faticoso, che richiede allo spettatore la capacità di buttarsi dentro a peso morto, avendo però la capacità/volontà di discernere (in ogni scena, in ogni battuta, in ogni personaggio) il privato e il sociale, il contingente e l’universale, il dramma individuale e il destino collettivo di una società mercificata. Uno dei più grandi drammi della storia del teatro.
Ottima l’interpretazione di De Capitani e accettabile le chiavi di lettura della regia. Non sempre l’impianto scenico, alcune soluzione espressive e la recitazione corale sembrano adeguati e all’altezza, ma il risultato finale è di sicuro valore.
Da vedere, avendo presente l’intera opera di Miller e , in particolare, Erano tutti miei figli, Uno sguardo dal ponte e The price. Le chiavi di lettura diventano più agevoli.